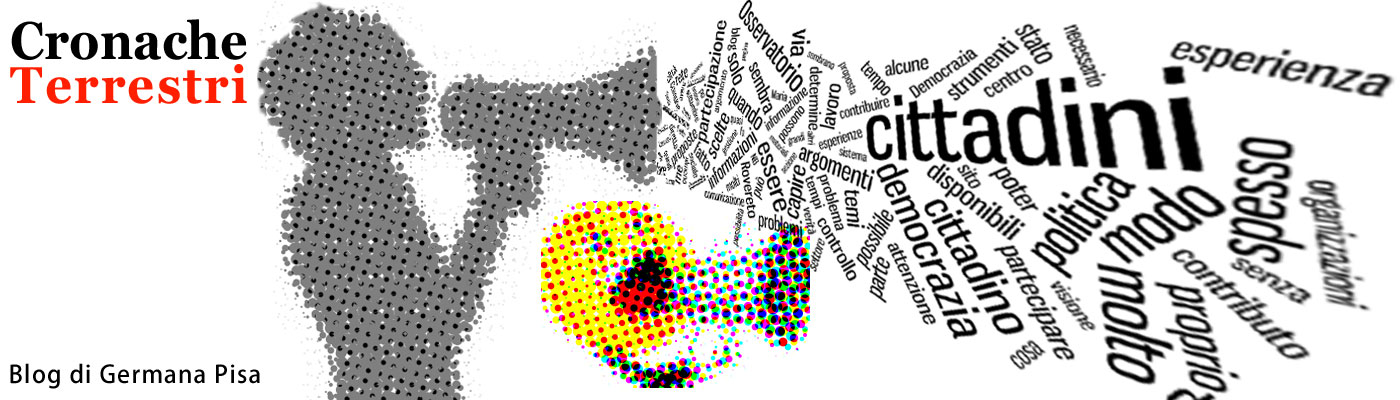La lotta per l’animo dell’uomo – par. 2
La Tv aveva assunto negli Stati Uniti, sin dalla fine della guerra mondiale, uno sviluppo straordinario, come uno dei principali prodotti della riconversione post-bellica. Tuttavia, mentre dilagavano i programmi commerciali, la pubblicità , i quiz e l’intrattenimento, i giornali televisivi restarono sacrificati nella durata e nell’efficacia, almeno fino al 1963, quando passarono da quindici a trenta minuti (spot pubblicitari compresi).
Il complesso dei mezzi di comunicazione risentiva del clima aspro della guerra fredda tra Est e Ovest, in cui il ruolo degli intellettuali e dell’informazione era stato efficacemente definito dal presidente Eisenhower nel 1953: “La lotta nella quale la libertà è oggi impegnata è letteralmente una lotta totale e universale…E’ una lotta politica…E’ una lotta scientifica…E’ una lotta intellettuale…E’ una lotta spirituale…Perchè la posta di questa lotta totale, nel suo senso più profondo, non è nè il suolo, nè il cibo, nè il potere, bensì l’anima stessa dell’uomo”.
Sul piano della struttura economica, l’afflusso di ingenti investimenti del Pentagono nel campo della comunicazione e dell’informatica contribuirà a determinare quella che anni dopo il senatore J. William Fulbright, a capo di una famosa commissione d’inchiesta, denuncerà come una parziale “militarizzazione dell’informazione”.
Sul piano dell’orientamento ideale, c’era una generale identificazione, affermatasi nei decenni e consolidatasi durante la seconda guerra mondiale, tra il sistema dell’informazione americano e la politica – anzi, “la missione” – mondiale degli Stati Uniti. Negli affari interni era presente -, è vero -, un margine di autonomia critica, che si manifestà in alcune coraggiose denunce del “New York Times” contro gli eccessi della caccia alle streghe del senatore McCarthy.
Totale era invece la coincidenza di punti di vista in politica estera e militare. In quest’ottica e in questo clima fu vissuta dall’opinione pubblica americana la guerra di Corea (non ancora coperta dalle immagini tv), giudicata sostanzialmente un prolungamento del conflitto armato degli anni ’40 con il dispotismo asiatico e le sue crudeltà (i “musi gialli” della retorica anti-giapponese nei film sulla guerra conclusa nel ’45), e insieme il primo atto di uno scontro inevitabile con “i rossi”, fossero essi sovietici o cinesi.
Scontro tra il bene e il male, tra il mondo delle nazioni civili (il corpo di spedizione americano combatteva, come avverrà quarant’anni dopo nel Golfo, sotto l’insegna dell’Onu) e la barbarie, la guerra di Corea fu seguita senza conflitti e senza dubbi dall’informazione. Ne rimasero in ombra, ancor più che nella successiva vicenda vietnamita, le radici nazionali, mentre in primo piano emergevano solo i motivi di contrapposizione ideologica. Anche per questo, sul reale svolgimento degli eventi bellici si ricordano oggi più le immagini eroiche della fiction di Hollywood che gli scarni resoconti giornalistici, scritti o documentari. Al punto che, secondo la definizione dell’esperto Usa di storia coreana Bruce Cumings, quella combattutasi nella penisola asiatica sul trentottesimo parallelo andrebbe definita, prima ancora che una “guerra dimenticata”, una “guerra sconosciuta”.
In Corea le corrispondenze dei giornalisti erano state sottoposte alle stesse restrizioni, dettate dalla censura militare, del secondo conflitto mondiale. Questo non avvenne invece in Vietnam. Gli inviati potevano seguire le truppe, parlare con i soldati, spedire i loro reportage senza bisogno di nessun visto speciale. Questo, lo abbiamo rilevato, non portò tuttavia, almeno per tutta una fase, ad una maggiore spregiudicatezza critica, nè ad una informazione più autonoma e penetrante. Il sistema dell’informazione era considerato, nel suo complesso, più adulto e capace di autoregolamentazione. Alla censura si era sostituita, nel cimento degli anni della guerra fredda, una autocensura che derivava dal senso di appartenenza dei comunicatori della tv e della carta stampata alla comune “missione americana”.
Secondo l’analisi di Hallin, come una sorta di branca del governo, con atteggiamento definito “responsabile”, l’informazione accettò “il linguaggio, le prospettive e l’agenda dell’establishment”.
Gli eroi dei reportage erano i piloti. L’intervista televisiva metteva in luce, nei pochi secondi concessi dal mezzo, il loro radicale e insieme casalingo punto di vista: “Qual è l’utilità dei bombardamenti aerei?”. “Risparmiare la vita degli americani”. “Non ti dà fastidio sparare sulle popolazioni civili e uccidere degli innocenti?” “Certo ma è necessario”.
L’offensiva terrestre del 9 febbraio 1966 fu seguita per la catena televisiva Abc dal famoso Dean Brelis. Ecco il suo resoconto: “Gli uomini coraggiosi hanno bisogno di leader. Questo è un leader di uomini coraggiosi. Il suo nome è Hal Moore. La sua città è Bardstown, nel Kentucky. E’ sposato, è padre di cinque figli (a questo punto si vede in primo piano l’immagine di Moore n.d.r.)…Essi sono i più grandi soldati del mondo. In effetti, sono i migliori uomini del mondo. Sono preparati, disciplinati. Tremenda è la loro motivazione. Sono venuti qui per vincere”.
A questo punto la telecamera inquadra l’anchor man della Abc Dan Rather, che parla del colonnello Moore: “E’ l’eroe di novembre della Ia Drang Valley, fremente nell’attesa di un altro scontro, frontale”.
Le distruzioni di obbiettivi civili erano al massimo considerate un “fatale errore”, più frequentemente un inevitabile corollario della guerra (come, trent’anni dopo, i “danni collaterali” nel conflitto del Golfo). Ecco Jack Perkins (Nbc) che racconta e spiega la distruzione di un villaggio vietnamita: “Questa non è insensibilità , nè distruzione deliberata…In questa zona ogni cosa è stata per anni vietcong…L’intero villaggio ha combattuto contro di noi, e dunque l’intero villaggio è stato distrutto”. Anche il noto Walter Cronkite, conduttore dagli studi della Cbs (prima di recarsi in missione lui stesso in Vietnam) divulgava senza nessuna presa di distanza critica “il giudizio dell’amministrazione Johnson” secondo cui i comunisti vietnamiti del sud “governavano con il terrorismo”. Di fronte alla tragedia di un autobus che aveva urtato contro una mina, il suo messaggio televisivo (14 febbraio 1966) fu: “Bene. Oggi la guerra ci ha fornito un maledetto esempio di quel terrorismo”.
Per tutto un periodo, le proteste contro la guerra erano considerate come un atto ostile, antipatriottico. Peter Jennings, notiziario Abc del 27 ottobre 1965: “Mentre gli americani combattono e muoiono in Vietnam, ci sono certuni, in questo paese, che simpatizzano con i vietcong”. A coloro – una minoranza via via crescente, ma pressochè invisibile – che sollevavano pubblicamente qualche dubbio, gli speaker e gli intervistatori chiedevano, retoricamente, se “erano mai stati là “. Il loro dissenso infatti, se non derivava da malafede, non poteva che essere frutto di superficialità ed ignoranza.
In realtà , come si incaricheranno di dimostrare gli eventi successivi, era proprio il sistema dell’informazione che nascondeva all’opinione pubblica la natura della guerra. Quando le immagini e i racconti, infatti, consentirono all’opinione pubblica, almeno in parte, di “andare a vedere là “, giudizi e sentimenti di massa, fino ad allora sostanzialmente consenzienti con l’avventura bellica, mutarono nel profondo.